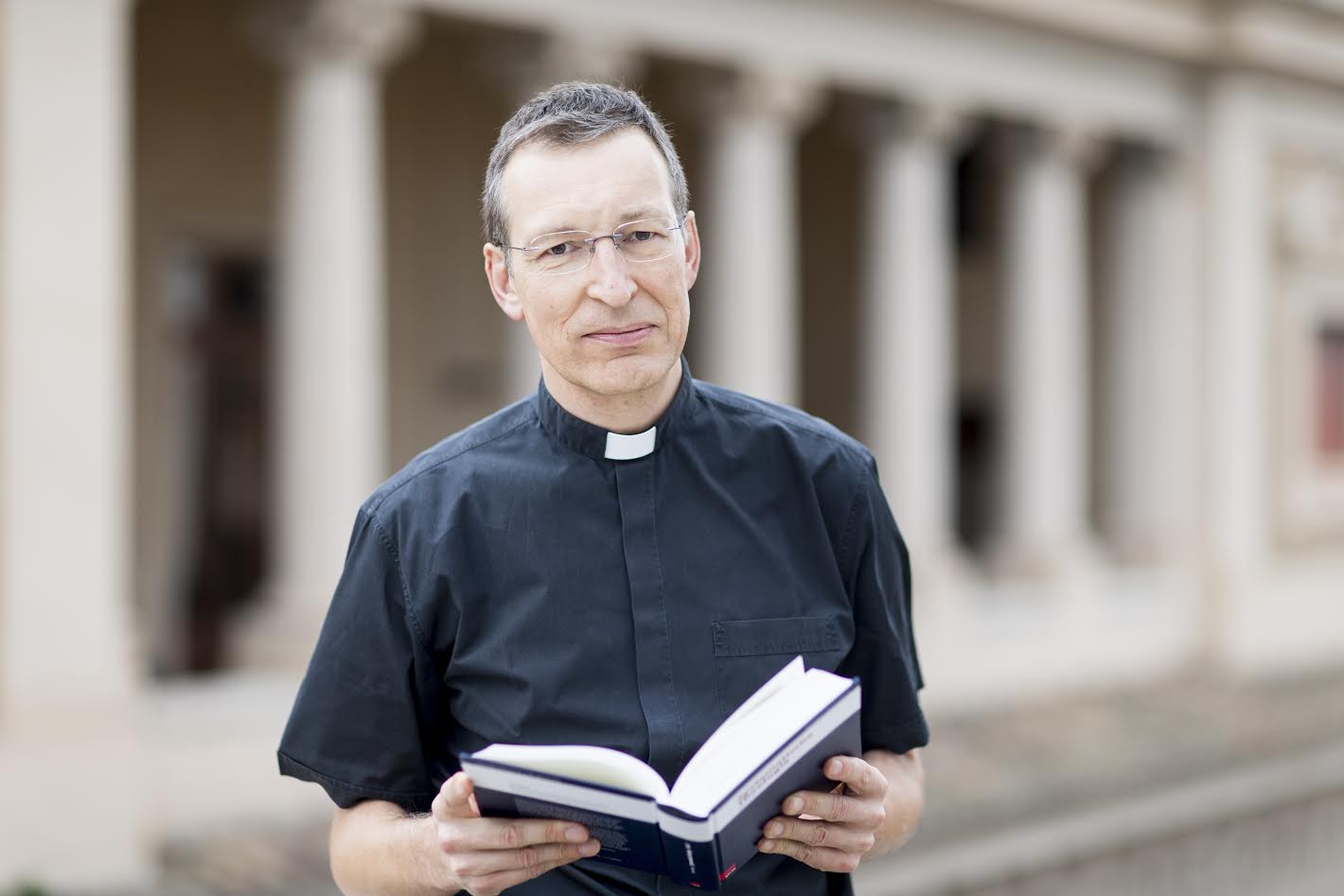
01 Set La forza di plasmare il mondo
Lo speciale “Quel che resta di Ratisbona” è a cura di Gabriele Palasciano. Un testo di Felix Korner SJ*.
[…] Già prima del suo pontificato, papa Ratzinger era conosciuto come il difensore della verità cattolica. Come può, allora, dire allo stesso tempo che la verità non è qualcosa di cui un essere umano può entrare in possesso? Esiste solamente una verità approssimativa? Non è proprio la gratitudine per il dono della verità che ci dà la fiducia di attraversare le tempeste di questi tempi? E adesso Benedetto ci sottrae la verità? Se la verità non è un dato oggettivo, deve essa dipendere dalla decisione individuale? Quindi dobbiamo dire noi cosa è vero e falso? Benedetto XVI, come sappiamo, ha detto un’altra volta di no. Critica proprio un tipo di fede che si basa sulla sola decisione del credente. Ma non è proprio la scommessa del credente quella di poter dire di sì in maniera decisiva di fronte alla verità evangelica? Nel pensiero di papa Ratzinger esiste chiaramente una tensione. Si tratta di una contraddizione interna? Verità cristiana: né possesso, né decisione?
La verità ce la possediamo, sì oppure no? La fede cristiana professa di avere la verità, di averla ricevuta, ma di averla ricevuta in una forma che non ne permette il possesso. Come comprendere tutto questo? Qui ci può venire in aiuto il modo in cui il Nuovo Testamento si riferisce alla realtà: esso parla di “mistero”. Rivelazione vuol dire che Dio ci ha affidato il suo mistero. Il mistero non è qualcosa che si possa comprendere pienamente; d’altra parte, la concezione cristiana del mistero non lo presenta in primo luogo come qualcosa di incomprensibile. Il mistero è, nella prospettiva biblica, il piano di Dio. Negli eventi della storia, Dio realizza questo suo piano. Per questa ragione, il mistero della volontà di Dio non è una cosa nascosta per sempre all’uomo. Gradualmente essa diventa sempre più ovvia. Però non è ancora presente, non è ancora pubblica nella sua completezza. Il piano di Dio è in via di realizzazione: si tratta di un mistero in atto.
Se, però, la totalità non è ancora evidente, il suo principio può già esser visibile. Sarebbe possibile un riassunto della storia mentre la storia è ancora in corso? Cogliere il principio di tutto? Sì. Il significato, lo scopo dell’insieme degli eventi di ogni tempo passato e futuro può esser condensato, anticipato in una figura. La fede cristiana pretende, anzi consiste nella professione che l’espressione più completa del tutto, il riassunto della completezza del mondo, è già presente. Dove? Nella risurrezione di Gesù: così suona la testimonianza della Chiesa sin dall’inizio. Una formula classica per dirla è: il mistero della volontà di Dio è di unificare tutto in Cristo (cf. Efesini 1,9). Ecco un riassunto della fede cristiana: Cristo è il mistero della storia ed si mostrerà come l’obiettivo di tutti gli eventi. Questo mistero ci è già dato in dono, ma come mistero, cioè come realtà da scoprire passo dopo passo.
A questo punto, risulta necessario porci un’ulteriore domanda: perché dovrebbe essere proprio in Cristo che tutto trova l’unità? Questa domanda, “perché?”, cambia tutto. Se non la ponessimo, diremmo che ognuno può fare la propria scelta in modo arbitrario, in privato, senza dover rispondere alle domande della ragione: siano esse le domande che ognuno porta in sé, siano esse le domande degli altri. Se poi questa domanda, “perché proprio Cristo?” ce la poniamo, diciamo allo stesso tempo, comunque, che non esiste un’evidenza immediata. Dice che dobbiamo fornire ragioni; ma che queste saranno ragioni che, anche se poste con grande chiarezza, non convinceranno tutti. Perché ritenere proprio Cristo come il mistero, perché ritenere proprio la storia di Gesù come il senso di tutto il mondo? Perché, suona la risposta – dopo esser stato ucciso a causa della sua fedeltà a Colui che chiamava il suo Padre Celeste –, egli fu risuscitato, e in questa risurrezione fu reso manifesto lo scopo dell’esistenza: tutto finisce nella comunione di vita piena. Perciò possiamo già oggi vivere nella dinamica di questa comunione. Una tale formula breve della fede cristiana è una risposta forte alla domanda: perché riconoscere proprio Gesù come il senso della vita? Perché nella sua risurrezione è aperto, svelato, il significato di ogni esistenza. La risposta certamente è forte; comunque dobbiamo anche renderci conto che non tutti si lasceranno convincere.
Quindi, una risposta a una domanda di vita non deve essere una sola fantasia, un bel pensiero fai-da-te. Sarebbe un atto di arbitrarietà, di autoreferenzialità. Sarebbe un rinchiudersi in se stesso, non un affidarsi all’altro. In questo senso è necessaria, per qualsiasi visione del mondo, un’oggettività: un punto di riferimento fuori di noi stessi. Ma non tutti ne saranno convinti durante la storia, quando ancora molto è nascosto. Perciò ogni riconoscimento del senso contiene anche un coinvolgimento personale.
Il Cristianesimo si comprende come fede, cioè come fiducia: abbiamo di fronte a noi quella storia di Cristo, la persona del Cristo e possiamo dire perché lo vediamo come il senso di tutto; ma comprendiamo anche perché non tutti possono vederlo così. Più precisamente, possiamo comprendere come altri pensano che la nostra storia non finirà in ciò che è divenuto presente nel Risorto.
Sì, c’è la verità cristiana, il mistero di Cristo a noi trasmesso; essendo affidato a noi, esso esige di essere testimoniato. Lo testimoniamo con una vita nella gioia della speranza e perciò nell’amore; e lo testimoniamo anche nelle parole; e non facciamo solo “teologia negativa”, dicendo ciò che Dio non è – no, facciamo “teologia testimoniale”, dicendo ciò che Dio è. È fedele e misericordioso – è amore – è il Padre di Gesù. Ma queste parole non sono definizioni; sono proposizioni che richiedono un dispiegarsi sempre più ampio. La verità cristiana è il mistero di Cristo, perciò non è verità da possedere, ma da scoprire e testimoniare. […]
>> Versione integrale del testo
*Felix Körner, nato nel 1963 a Offenbach, Germania, gesuita dal 1985, è islamologo e teologo. Ha vissuto in Turchia per sei anni ed è professore di dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana. Insegna la teologia sacramentaria e dialogo interreligioso. La sua ricerca si concentra sui metodi ermeneutici dell’esegesi coranica.
